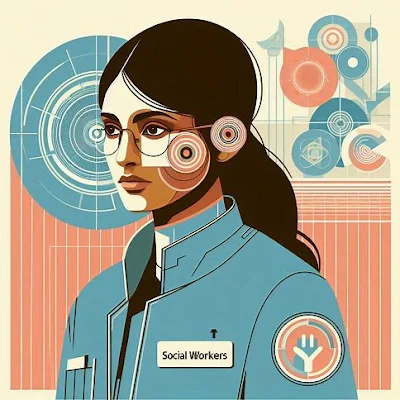Introduzione: crisi economica, politica e sfide dell’internet economy
Il contesto economico e politico attuale è caratterizzato da una complessità crescente e da trasformazioni profonde, dovute alla crisi della globalizzazione neoliberale, all’instabilità geopolitica e alla diffusione accelerata delle tecnologie digitali, che modificano radicalmente i modelli di produzione, lavoro e partecipazione sociale. L’economia digitale (internet economy) impone nuove modalità di governance e di organizzazione, che incidono anche sui processi di rappresentanza e sulle forme di leadership.
In tale scenario, il Terzo Settore emerge come spazio cruciale di innovazione sociale, capace di tessere relazioni tra mercato, istituzioni e comunità. La sfida principale riguarda la capacità di sviluppare modelli di leadership che superino i limiti dei tradizionali approcci manageriali, spesso gerarchici e verticali, per adottare forme più fluide, distribuite e generative.
Leadership postmanageriale e generativa: definizioni e riferimenti teorici
La leadership postmanageriale si distingue per un approccio meno autoritario, fondato su pratiche di collaborazione, condivisione del potere e valorizzazione della soggettività collettiva. La leadership generativa, collegata a questa, si concentra sull’emergere di nuove soggettività e sulla costruzione di significati condivisi, attivando processi creativi e trasformativi all’interno delle organizzazioni.
Il contributo della psicoanalisi lacaniana risulta fondamentale per interpretare la leadership come funzione simbolica. Secondo tale prospettiva, la leadership agisce come “significante padrone” che organizza e stabilizza il campo sociale e simbolico, ma che nel modello generativo non si manifesta come imposizione rigida, bensì come apertura a un campo plurale, in cui più soggettività trovano spazio e possibilità di espressione.
La leadership nel Terzo Settore: pratiche distribuite e soggettività generative
Nel Terzo Settore, che include cooperative sociali, associazioni, enti non profit e realtà di economia sociale, la leadership generativa si manifesta in forme situate, distribuite e relazionali. Queste forme si fondano su valori di partecipazione, inclusione e mutualità, distinguendosi da modelli aziendalistici tradizionali.
Gli operatori sociali, educatori professionali, psicologi e figure di coordinamento svolgono funzioni di leadership diffusa, in cui il ruolo formale non coincide con l’esercizio effettivo della funzione simbolica di guida e facilitazione. La leadership qui è lavoro simbolico e relazionale, capace di integrare le diversità e di favorire processi di empowerment.
Esempio 1: un progetto di inclusione sociale in una grande città
In un’organizzazione dedicata all’inclusione sociale di persone in situazione di vulnerabilità, la leadership è distribuita tra educatori, mediatori culturali e coordinatori, che insieme costruiscono spazi di dialogo e decisione condivisa. La pratica di leadership generativa ha permesso di superare rigidità organizzative e di valorizzare le competenze e le esperienze dei singoli, migliorando la qualità degli interventi e la coesione interna.
Esempio 2: una rete territoriale per il sostegno alle famiglie
Una rete di enti del Terzo Settore impegnata nel sostegno alle famiglie ha sviluppato un modello di leadership situata, in cui i leader locali agiscono come facilitatori di processi di co-progettazione e mediazione tra diversi attori sociali. La leadership non è concentrata in un singolo soggetto, ma si distribuisce e si adatta alle diverse situazioni, promuovendo una governance partecipata e inclusiva.
Sindacalismo critico: laboratorio di leadership generativa
Anche nel campo sindacale, in particolare nei sindacati di base, si osserva un’importante evoluzione verso forme di leadership generativa e distribuita. Questi sindacati promuovono pratiche di autorganizzazione, partecipazione diretta e costruzione collettiva di strategie, mettendo in discussione i modelli tradizionali di rappresentanza verticale.
In questo contesto, la leadership si esprime come capacità di attivare soggettività multiple, riconoscere la pluralità delle identità lavorative e mediare i conflitti trasformandoli in momenti di innovazione sociale e culturale.
Esempio 3: rappresentanza dei lavoratori della gig economy
Un sindacato di base ha avviato una campagna di rappresentanza per lavoratori della gig economy, tipicamente frammentati e privi di tutele tradizionali. La leadership collettiva e assembleare ha permesso di costruire reti di solidarietà e di rivendicazione che intrecciano istanze economiche con pratiche culturali, favorendo una nuova soggettività politica dei lavoratori digitali.
Il ruolo di psicologi e educatori nel Terzo Settore
Psicologi, educatori professionali e assistenti sociali sono attori fondamentali della leadership generativa nel Terzo Settore. Non solo svolgono compiti tecnici, ma incarnano funzioni simboliche e relazionali che favoriscono la soggettivazione degli utenti, la mediazione culturale e la costruzione di comunità inclusive.
Gli psicologi, in particolare, contribuiscono come mediatori simbolici, sostenendo la trasformazione dei conflitti in risorse e facilitando processi di empowerment. Gli educatori professionali, con la loro capacità di facilitare dinamiche di gruppo e di relazione, rappresentano spesso nodi centrali nella rete di leadership distribuita.
Conclusioni
La leadership postmanageriale e generativa nel Terzo Settore si configura come una risposta strategica alle sfide poste dalle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche in atto. Essa implica una ridefinizione della leadership stessa, intesa come processo collettivo, distribuito e situato, capace di integrare dimensioni simboliche, relazionali e organizzative.
In questa prospettiva, il Terzo Settore diventa un laboratorio privilegiato per sperimentare forme di leadership che siano creative, inclusivi e politicamente significative, contribuendo a costruire comunità resilienti e capaci di innovazione sociale.
Bibliografia essenziale
- Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Addison-Wesley.
- Bennis, W. G. (2003). On Becoming a Leader. Basic Books.
- Foster, R., & Kaplan, S. (2001). Creative Destruction. Crown Business.
- Lacan, J. (1972). Le séminaire, Livre VIII: Le transfert. Seuil.
- Magatti, M. (2019). La società in guerra. Il Mulino.
- Ricketts, E. (2018). Generative Leadership in Practice. Palgrave Macmillan.
- Ropo, A., & Salovaara, P. (2017). Leadership-as-Practice. Routledge.
- Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline. Doubleday.
- Wheatley, M. J. (2006). Leadership and the New Science. Berrett-Koehler.