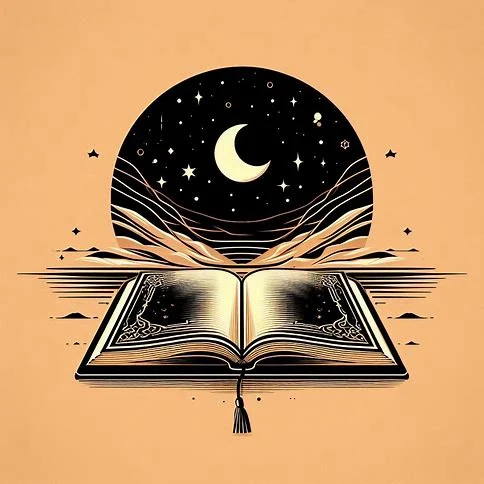La metafisica subordinativa occidentale è il frutto di una lunga tradizione filosofica che ha cercato di risolvere, rappresentare e ordinare la realtà attraverso un principio che subordinasse l'individuo o il mondo a un ordine superiore, trascendente, razionale o simbolico. Nel corso della storia della filosofia, questa subordinazione ha assunto forme diverse, ma ha sempre implicato una limitazione del soggetto e della sua libertà in favore di un ordine più ampio. In questo percorso, la metafisica occidentale si è confrontata con il Reale e con il resto (ciò che sfugge all’ordine simbolico), e questo confronto diventa centrale nella risignificazione psicoanalitica proposta da Lacan.
1. Le Origini: I Presocratici e Platone
Nei Presocratici, la subordinazione si manifesta nel tentativo di identificare un principio unico e universale che regolasse l'universo. Per Eraclito, questo principio era il Logos, una legge che subordinava l'intero flusso di eventi, creando un ordine. Ma c’era anche un altro aspetto, legato al resto: l’idea che il Logos potesse essere inaccessibile o parzialmente comprensibile. Anche per Parmeneide, la realtà è subordinata a un principio dell’essere che rifiuta la molteplicità, ma il suo pensiero lascia intendere un resto: l’impossibilità di pensare pienamente l'essere e il non-essere.
In Platone, la subordinazione è legata all'idea delle Idee. Il mondo sensibile è subordinato al mondo delle Idee, ma le Idee sono incompletable, ci sfuggono, lasciando dietro di sé un vuoto o un resto. Platone non può rendere completa la conoscenza del mondo delle Idee e lascia un aspetto inaccessibile, qualcosa che non può essere pensato. Questa tensione tra il principio subordinato e il resto diventa un tema ricorrente.
2. Aristotele: Subordinazione e Finalismo
Per Aristotele, la subordinazione si configura in termini di causa finale. L’universo è subordinato a un fine naturale e ogni ente ha una funzione in un ordine teleologico. Ma anche qui emerge il resto: la molteplicità della realtà non può essere completamente ridotta a un principio finale e la percezione dell’ordine stesso lascia spazio a quello che non può essere compreso del tutto. La causa finale rimane, in certo senso, impenetrabile e sfuggente.
3. Il Medioevo: Subordinazione al Divino
Nel pensiero medievale, la subordinazione raggiunge la sua espressione più forte con l’affermazione di un ordine divino che governa il mondo. Tommaso d’Aquino afferma che l’uomo è subordinato alla volontà divina e al disegno divino. L’uomo, il mondo e l’universo sono subordinati all’essere di Dio. Tuttavia, in questo schema esiste sempre qualcosa che rimane incomprensibile o misterioso: il resto. Il mistero di Dio, la sua volontà, è sempre al di là della comprensione umana, creando una tensione tra ciò che è conoscibile e ciò che sfugge.
4. La Modernità: Razionalità e Limiti della Conoscenza
Con la modernità, la subordinazione si sposta dalla sfera teologica a quella razionale. In Cartesio, l’individuo è subordinato alla ragione come fondamento della conoscenza certa. La ragione è il criterio che permette di risolvere l’incertezza. Tuttavia, anche per Cartesio, vi è un resto: il dubbio cartesiano, la consapevolezza che non è possibile afferrare tutto con certezza, ma solo quella porzione di realtà che la ragione può chiaramente percepire. Il Reale rimane una parte sconosciuta, esterna alla ragione.
Nel pensiero di Kant, la subordinazione del soggetto si manifesta nelle strutture a priori che filtrano la realtà. L'uomo è subordinato a categorie che organizzano l'esperienza, ma il Reale (il noumeno) resta al di fuori del nostro accesso diretto, irraggiungibile, e rappresenta proprio il resto che sfugge al nostro sistema di conoscenza. Per Kant, il soggetto è sempre limitato e subordinato a un sistema di rappresentazioni che non può mai completamente cogliere la realtà in sé.
5. Filosofia Contemporanea: Il Linguaggio e la Subordinazione al Simbolico
Nel pensiero contemporaneo, il linguaggio e il simbolico diventano il luogo della subordinazione. Heidegger pone l’accento sul fatto che l'uomo è subordinato al linguaggio e al tempo. Il linguaggio non è un semplice strumento del pensiero, ma lo struttura e lo limita. Anche il rapporto con l’essere è subordinato a una rivelazione frammentaria e storica che non consente una comprensione totale. In questo quadro, il Reale resta fuori dalla nostra portata, come un "essere" che non può mai essere completamente afferrato dal soggetto umano.
Nietzsche rovescia il concetto di subordinazione: l’individuo deve rompere con ogni tipo di ordine trascendente o razionale, in un atto di affermazione della propria volontà di potenza. Tuttavia, la volontà di potenza non è mai totalmente libera; è sempre subordinata a conflitti, desideri e tensioni. Il Reale in Nietzsche è la lotta per il potere, un potere che sfugge sempre alla completa realizzazione, rimanendo in una costante dialettica di affermazione e negazione.
6. Lacan: Subordinazione al Significante e al Linguaggio
In Lacan, la metafisica subordinativa prende una forma radicalmente nuova. Il soggetto è subordinato al linguaggio e ai significanti che lo costituiscono. Il S1 (significante padrone) diventa il concetto centrale: l’individuo è sempre sotto il dominio di un significante che precede la sua esperienza e lo struttura, dando forma al suo inconscio. La subordinazione lacaniana non riguarda solo un principio ontologico o razionale, ma è un effetto della relazione simbolica in cui il soggetto è intrappolato. Il Reale, per Lacan, è ciò che sfugge a questa simbolizzazione: è l’aspetto del mondo che non può essere interamente ridotto al linguaggio o al significante.
Il resto per Lacan è ciò che non può essere detto, ciò che il linguaggio non può esprimere, ma che comunque si manifesta nel desiderio, nei sintomi e nelle lacune del significante. Il soggetto è sempre intrappolato tra il simbolico (ciò che è rappresentabile) e il Reale (ciò che sfugge), e la sua esistenza è definita proprio da questa tensione tra ciò che può essere detto e ciò che resta taciuto, tra il simbolico e l’impossibile.
7. Conclusioni: Persistenza della Subordinazione e Il Reale
Nel corso della storia della filosofia, la subordinazione è sempre stata una parte integrante del modo in cui l’uomo ha cercato di comprendere e orientarsi nel mondo. Se la metafisica occidentale ha cercato di subordinare l’individuo e la realtà a principi trascendenti, razionali o simbolici, il pensiero contemporaneo e la psicoanalisi lacaniana rivelano che questa subordinazione non è mai completa. Il Reale sfugge sempre alla totalizzazione simbolica e lascia un resto che non può essere ridotto a un ordine razionale o linguistico.
La metafisica subordinativa occidentale, quindi, può essere vista come la storia di un tentativo costante di fare i conti con il Reale senza abolire il principio subordinativo, ma riconoscendo che esiste sempre una parte di realtà che rimane fuori dalla nostra portata, un resto che non possiamo simbolizzare o rappresentare completamente.
Bibliografia:
- Platone, La Repubblica.
- Aristotele, Metafisica.
- Tommaso d'Aquino, Somma Teologica.
- René Descartes, Meditazioni metafisiche.
- Immanuel Kant, Critica della ragion pura.
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello spirito.
- Martin Heidegger, Essere e tempo.
- Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra.
- Jacques Lacan, Écrits.
- Panayotis Kantzas, Il Seminario permanente. "La polis senza Creonte e senza Antigone. La politica senza Legge e senza Desiderio" 2012-2017