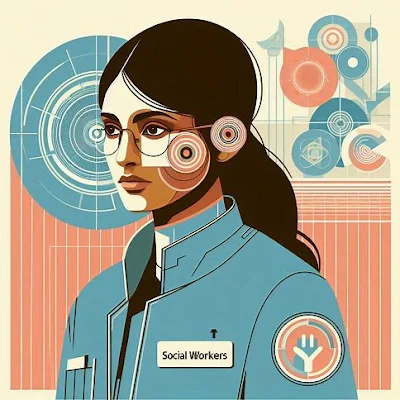1. Il vuoto come esperienza concreta nei servizi
Nel lavoro quotidiano nei servizi socio-sanitari ed educativi, il vuoto si presenta come esperienza concreta: momenti di sospensione, inattività, silenzio. Pause improvvise nel ritmo istituzionale, tempi morti tra un’attività e l’altra, assenze che sembrano pesare sull’atmosfera. Talvolta, questi vuoti sono vissuti come errori da colmare, falle nel dispositivo da riparare. Eppure, se ci si sottrae alla logica dell’efficienza immediata, si può riconoscere in questi interstizi il riemergere del reale, quell’eccedenza che sfugge all’organizzazione e che interroga profondamente la nostra posizione etica di operatori.
2. Vuoto, desiderio e mancanza nel soggetto
La psicoanalisi lacaniana ci invita a un'altra lettura: il vuoto non è assenza di senso, ma condizione strutturale del desiderio. Il soggetto umano si costituisce attorno a una mancanza originaria – il manque-à-être – che non va colmata, ma riconosciuta e sostenuta. Lacan afferma che “non c’è atto simbolico se non nel vuoto” (Seminario V): è nel vuoto che può emergere un nuovo significante, un atto soggettivo. In questa luce, i momenti “vuoti” nel lavoro educativo o terapeutico non sono da eliminare, ma da abitare con rispetto.
3. Il disagio degli operatori di fronte al vuoto
Nelle équipe, il vuoto mette spesso in crisi l’identificazione con un ideale di efficienza e di progettazione continua. L’operatore che si confronta con un’utenza silenziosa, apatica, non cooperante, può sentirsi inutile o inadeguato. Il rischio è la reazione ansiosa: colmare subito, agire, riempire. Ma questa risposta rischia di negare il tempo del soggetto e l’opportunità del desiderio. È necessario uno spostamento: dalla prestazione alla presenza, dalla fretta al rispetto per il tempo logico del soggetto.
4. Il tempo logico e l’attesa significativa
Lacan distingue il tempo cronologico da quello logico: il soggetto non si costituisce nel tempo lineare, ma attraverso rotture, sospensioni, atti. L’etica istituzionale che accoglie questa logica può offrire spazi dove il tempo del soggetto sia rispettato, e dove il desiderio possa articolarsi senza essere spinto o ridotto a bisogno. È la capacità di attendere senza esigere che rende fecondo un incontro. L’operatore che sa attendere senza forzare assume una posizione prossima a quella dell’analista.
5. Esempi clinici e quotidianità del vuoto
Pensiamo a un adolescente in un centro educativo che non partecipa alle attività, rifiuta ogni dialogo, sembra non volere nulla. La tentazione è quella di “fare qualcosa”: organizzare, intervenire, proporre. Ma può essere proprio l’assenza di intervento diretto, il rispetto per quel ritiro, a creare uno spazio dove qualcosa accada. Un giorno, forse, quel ragazzo chiede una musica, una frase, uno sguardo: in quel momento il soggetto ha occupato il vuoto con un proprio gesto.
6. Il vuoto come occasione di soggettivazione
Come ricorda Massimo Recalcati nella sua Clinica del vuoto, è nell’assenza dell’Altro che garantisce – nel tempo in cui il grande Altro si mostra mancante – che può emergere la soggettività autentica. Non si tratta di abbandono, ma di sostegno non intrusivo. Il vuoto non è il nulla, ma il luogo potenziale dove il soggetto può produrre un atto proprio, non imposto, non eterodiretto. Anche nelle riunioni d’équipe, momenti di disorientamento o sospensione progettuale possono divenire, se ben accolti, spazi di elaborazione collettiva e di ripensamento dell’azione.
7. Etica della presenza e clinica dell’inconsistenza
Questa pratica del vuoto richiede una trasformazione della posizione dell’operatore: non più colui che offre sempre senso, ma colui che sa sostenere l’inconsistenza del sapere. Una presenza che non pretende, che non chiude, che non anticipa. Si tratta, in termini lacaniani, di “occupare il posto dell’oggetto a”, ovvero sostenere la mancanza dell’Altro senza volerla saturare. Questo è il vero atto clinico, che riguarda tanto l’istituzione quanto la relazione uno per uno.
8. Conclusione: una politica della mancanza
In un tempo istituzionale dominato dalla logica dell’efficienza, accogliere il vuoto è un gesto clinico e politico. È un’etica dell’attesa, della presenza non saturante, della fiducia nel tempo soggettivo. Il vuoto, lungi dall’essere un fallimento, è ciò che rende possibile l’invenzione, la parola, l’atto. È lì che può emergere il soggetto, con il proprio tempo, la propria voce, la propria mancanza.
Bibliografia
- Lacan, J. (1957-58). Il Seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio. Torino: Einaudi.
- Lacan, J. (1966). Scritti. Torino: Einaudi.
- Recalcati, M. (2010). Clinica del vuoto. Milano: Raffaello Cortina.
- Heidegger, M. (1927). Essere e tempo. Milano: Longanesi.
- Fink, B. (1995). The Lacanian Subject. Princeton University Press.